Italiani nel Mondo
La Giornata Mondiale della Lingua Madre e l’importanza dei dialetti–World Mother Language Day and the importance of dialects
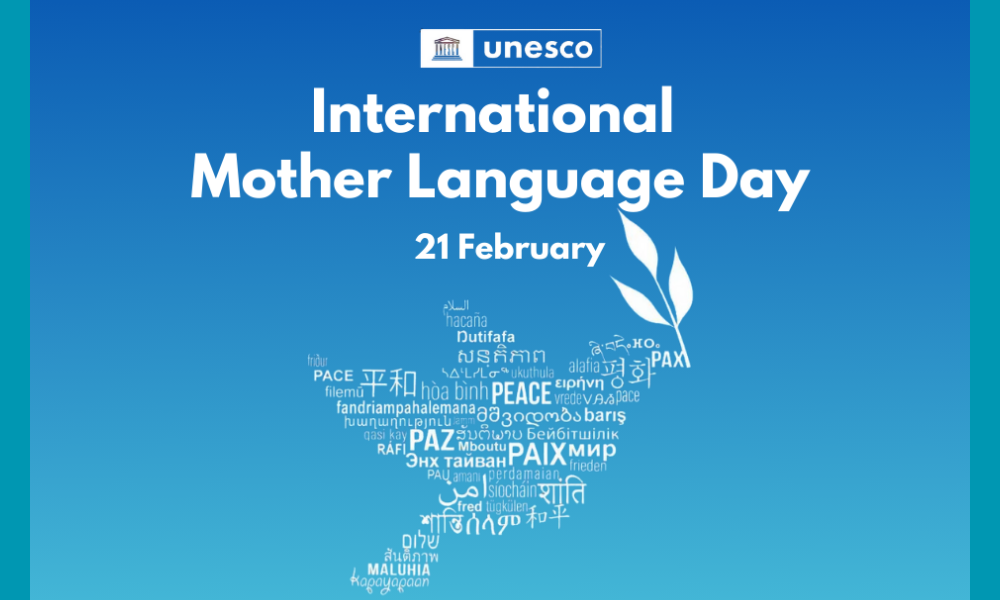
La Giornata Mondiale della Lingua Madre e l’importanza dei dialetti
di Carmelina Micallef
Ogni anno, il 21 febbraio, il mondo celebra la Giornata Mondiale della Lingua Madre, istituita dall’UNESCO nel 1999 per promuovere la diversità linguistica e proteggere le lingue a rischio di estinzione. La scelta di questa data commemora il sacrificio di alcuni studenti del Bangladesh, uccisi nel 1952 mentre lottavano per il riconoscimento del bengalese come lingua ufficiale. Oggi, questo evento assume un significato ancora più profondo, in un’epoca in cui molte lingue e dialetti rischiano di scomparire sotto la pressione della globalizzazione.
Fino all’Unità d’Italia nel 1861, la stragrande maggioranza della popolazione parlava dialetti locali, che ancora oggi rappresentano un elemento essenziale del patrimonio culturale del Paese. Dialetti come il napoletano, il siciliano, il veneto, il lombardo e il piemontese raccontano la storia delle regioni che hanno influenzato profondamente la musica, il teatro e la letteratura italiana. Salvaguardarli non significa solo preservare parole e modi di dire, ma anche mantenere viva una parte dell’identità nazionale.
L’importanza dei dialetti non si limita all’Italia. Anche l’inglese, una delle lingue più parlate al mondo, ha una storia evolutiva complessa, con numerosi accenti e varianti che riflettono tradizioni locali. Oltre al Cockney, parlato nell’East End di Londra e ai dialetti delle Midlands e del Nord, nel Galles si parla il gallese, mentre in Scozia coesistono diverse varianti linguistiche. Questa ricchezza dimostra come il linguaggio sia un elemento vivo, strettamente legato all’identità culturale e storica di ogni regione.
Fino a qualche decennio fa, in Italia il dialetto era prevalentemente usato in ambito familiare e nei contesti informali, mentre l’italiano standard veniva appreso a scuola, quasi come se si trattasse di due sistemi linguistici separati. Un fenomeno simile si riscontrava anche in Gran Bretagna dove i dialetti locali erano spesso considerati “rozzi” e privi di prestigio, mentre il “Queen’s English” era il modello linguistico elevato a modello di status sociale e raffinatezza.
Un aspetto affascinante legato all’emigrazione è il fenomeno dell’ “italiese”, un linguaggio ibrido nato dall’incontro tra italiano e inglese. Questo miscuglio linguistico ha dato vita a nuove parole, né completamente italiane né completamente inglesi, ma uniche nel loro genere. Gli emigrati, nel tentativo di integrarsi nel nuovo mondo, creavano un linguaggio che rifletteva perfettamente la loro esperienza di adattamento. Talvolta buffe, queste espressioni rendevano la comunicazione più immediata ed efficace, sia in contesti lavorativi che sociali. L’Italiese rappresentava un vero e proprio tentativo di “trovare una via di mezzo” tra la cultura di origine e quello del paese di accoglienza. Spesso però queste espressioni venivano liquidate con sufficienza come “errori linguistici”, senza comprendere che in realtà erano una straordinaria dimostrazione di flessibilità e di ingegno, qualità che i presunti custodi della “correttezza linguistica” non erano in grado di cogliere.
Negli ultimi anni, si è capito che la lingua madre gioca un ruolo fondamentale nell’apprendimento. Per questo motivo, molte scuole stanno adottando metodi che favoriscono l’apprendimento simultaneo di più lingue, come il bilinguismo e il multilinguismo. Questi approcci non solo facilitano la comprensione delle materie, poiché gli studenti possono fare affidamento sulla loro lingua principale per assimilare concetti nuovi, ma rendono anche l’istruzione più inclusiva e accessibile a tutti.
In un mondo sempre più interconnesso, la lingua dovrebbe unire non dividere.
Tuttavia, senza l’impegno a tutelare le lingue madri e i dialetti, rischiamo di trovarci immersi in un linguaggio che pur sembrando familiare, perde il suo vero significato. Preservare la diversità linguistica significa custodire e rispettare la cultura, la memoria e l’identità di ogni popolo.
World Mother Language Day and the importance of dialects
by Carmelina Micallef
Every year, on the 21st of February, the world celebrates International Mother Language Day, established by UNESCO in 1999 to promote linguistic diversity and protect languages at risk of extinction. This date was chosen to commemorate the sacrifice of a group of students in Bangladesh who were killed in 1952 while fighting for the recognition of Bengali as an official language. Today, this event carries even greater significance in an era where many languages and dialects are at risk of disappearing under the pressures of globalisation.
Until the unification of Italy in 1861, the vast majority of the population spoke local dialects, which still represent an essential part of the country’s cultural heritage. Dialects such as Neapolitan, Sicilian, Venetian, Lombard and Piedmontese tell the story of the regions that have deeply influenced Italian music, theatre, and literature. Preserving these dialects means not only safeguarding words and expressions but also keeping alive an important part of national identity.
The importance of dialects is not limited to Italy.
English, one of the most widely spoken languages in the world, also has a complex history with numerous accents and variations reflecting local traditions. Beyond Cockney, spoken in the East End of London, and dialects from the Midlands and the North, Welsh is spoken in Wales, while in Scotland, several linguistic variants coexist. This richness demonstrates how language is a living element, closely tied to the cultural and historical identity of each region.
In Italy, dialect was primarily used in family and informal settings, whereas standard Italian was taught in school, almost as if the two were separate linguistic systems. In Britain, local dialects were often considered less prestigious than the so-called “Queen’s English,” which was regarded as a model of social status and refinement.
Linked to migration is “italiese”, a hybrid language born from the combination of Italian and English. This linguistic mix gave rise to new words, neither fully Italian nor fully English, but unique in their own way. In trying to integrate, Italian immigrants created a language that reflected their experience of adapting to a new society.
Often amusing, these expressions made communication more immediate and effective, both at work and in social settings. Italiese represented a genuine effort to bridge the gap between the culture of origin and that of the host country. Nevertheless, these expressions were sometimes dismissed as “linguistic errors” overlooking the fact that they were, in reality, a reflection of flexibility and creativity, qualities that the so-called “guardians of linguistic correctness” failed to appreciate.
It’s now clear that a native language plays an important role in learning, as it is constantly evolving and shaped by the people who use it. As a result, many schools are adopting methods that encourage bilingualism or multilingualism. These approaches enable students to engage more effectively with their studies by using their Mother Tongue to better understand new concepts.
In a world that is more connected than ever, language should unite rather than divide.
If we don’t make an effort to preserve mother tongues and dialects, we risk losing the cultural richness that gives language its true meaning, leaving us with words that may sound familiar but feel empty of their deeper significance. This is what this celebration is all about!















