Arte & Cultura
Arte, cultura e politica in movimento: un viaggio tra Venezia, l’Abruzzo e le regioni adriatiche del Regno di Napoli

Convegno internazionale all’Università degli Studi di Teramo, frutto dell’iniziativa di due giovani studiose: Chiara Di Carlo e Martina Leone, che indaga sui legami tra Venezia e Abruzzo nel periodo tra XVI e XVIII secolo. Intervista a Chiara Di Carlo.
di Laura Marà
Teramo – 10-11 aprile 2024. Un ponte di storia, arte e cultura ha unito per due giornate le sponde dell’Adriatico, da Venezia all’Abruzzo, passando per le regioni del Regno di Napoli. Questo il cuore pulsante del convegno internazionale “Arte, cultura e politica in movimento: la Serenissima, l’Abruzzo e le regioni adriatiche del Regno di Napoli (XVI-XVIII secolo)”, tenutosi all’Università degli Studi di Teramo, frutto dell’iniziativa e della passione di due giovani studiose: Chiara Di Carlo e Martina Leone, entrambe storiche dell’arte e dottorande dell’ateneo abruzzese.
Un incontro che ha avuto il sapore della riscoperta e della rivisitazione critica di una pagina storiografica spesso trascurata: i legami, complessi e fruttuosi, tra i territori della Serenissima e le terre abruzzesi, in un arco temporale che va dal Cinquecento al Settecento. Due giornate fitte di interventi, discussioni e scambi tra studiosi di varie discipline: storia dell’arte, storia moderna, economia, collezionismo, storia del libro e delle idee.
Oltre i confini storiografici: un orizzonte da ripensare
La narrazione dominante del Novecento ha privilegiato i legami artistici tra Abruzzo e i grandi poli di Firenze e Roma. Ma i confini dell’arte sono mobili, proprio come le rotte marittime dell’Adriatico. Da qui nasce il desiderio delle due studentesse di rimettere al centro l’asse Venezia-Abruzzo, un tracciato ricco di migrazioni artistiche, scambi culturali, trasferimenti di opere e influenze reciproche.
Jacobello da Fiore, Girolamo Pittoni, Vincenzo Damini, solo per citarne alcuni, sono testimoni di un flusso creativo che da Nord raggiunge il cuore dell’Italia centrale. Ma il fenomeno non è unidirezionale: anche l’Abruzzo ha lasciato le sue impronte a Venezia, come dimostra il percorso del pittore camplese Giovan Battista Boncori, che da Roma giunge alla laguna.
Tra arte e artigianato: le rotte della creatività

Il convegno ha evidenziato come le dinamiche artistiche non possano essere disgiunte da quelle economiche e sociali. Non solo pittori e scultori, ma anche carpentieri, ceramisti, orafi, falegnami e collezionisti partecipano a questo fitto intreccio. Le merci viaggiano, i materiali si spostano, le idee si contaminano. Un piccolo mondo globale, in piena età moderna.
Ne è un esempio l’intervento di Isabella Campagnol sugli arabeschi di merletto tra Venezia e l’Abruzzo, o quello di Van Verrocchio sul collezionismo a Chieti. Filo conduttore è l’idea che l’arte non sia solo produzione visiva, ma riflesso e motore di movimenti più ampi, economici, sociali e culturali.
Un volume per ricucire le trame del passato

Il convegno si lega direttamente alla pubblicazione del volume omonimo, curato dalle stesse Chiara Di Carlo e Martina Leone, che raccoglie contributi inediti su questo dialogo adriatico. Una vera e propria “archeologia della relazione”, dove manoscritti, dipinti, incisioni e documenti diventano tessere di un mosaico storico ancora in costruzione.
Tra i saggi più apprezzati, quello di Federica Giamattei sui polittici di Atri, e l’indagine di Laura Palombaro su un misterioso Tiziano negli Abruzzi del Seicento. E ancora, le incursioni veneziane nei conventi cappuccini raccontate da Pietro Costantini e l’attività del pittore Vincenzo Damini analizzata da Marco Vaccaro.
Chi sono le ideatrici
Chiara Di Carlo ha svolto il dottorato presso l’Università degli Studi di Teramo ed è in attesa del conferimento del titolo, con una tesi intitolata Per un atlante del patrimonio storico e artistico della Valle Siciliana. Attualmente è borsista di ricerca presso il CeDiPa, centro interuniversitario dell’Università degli Studi di Perugia, dove conduce uno studio dedicato ai depositi di emergenza nell’Abruzzo teramano.
Martina Leone ha svolto il dottorato presso l’Università degli Studi di Teramo ed è in attesa del conferimento del titolo. È specializzata in pittura barocca, ha in preparazione un volume dedicato a Francesco Ruschi (1600-1661), pittore del Seicento poco conosciuto ma di grande interesse per le dinamiche culturali tra Venezia e Sud Italia.
Intervista alla dott.ssa Chiara Di Carlo
C’è stato un momento preciso in cui ha capito che l’arte sarebbe stata il suo percorso?
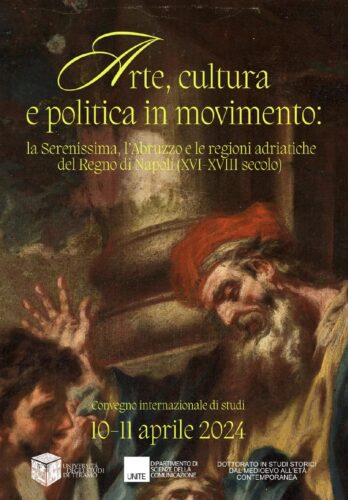
Durante l’ultimo anno della laurea triennale in Lettere moderne, ho scoperto la passione per l’arte grazie a un esame a scelta, un corso monografico su Scipione Pulzone. Quell’insegnamento ha segnato una svolta: da quel momento ho iniziato a guardare Roma con occhi nuovi. Entravo nelle chiese spinta da una curiosità insaziabile, desiderosa di comprendere, conoscere e dare un significato a ciò che vedevo. È stato allora che ho deciso di proseguire gli studi magistrali in Storia dell’arte, seguendo una passione sempre più forte, in particolare per le incisioni. Poi il dottorato di ricerca, la borsa di ricerca e il mondo lavorativo.
Cosa l’ha spinta a indagare i rapporti tra la Serenissima e l’Abruzzo, un tema ancora così poco esplorato?
Una fortunata coincidenza ha dato origine a tutto. La mia collega, la dott.ssa Martina Leone, durante il suo dottorato si è occupata del pittore romano Francesco Ruschi, attivo soprattutto a Venezia. Io, invece, ho concentrato la mia ricerca sull’arte dell’Abruzzo teramano. Confrontandoci ci siamo rese conto che, tra Quattrocento e Settecento, i legami tra le rispettive aree di studio erano numerosi, ma ancora poco esplorati dalla storiografia. Da questa consapevolezza è nata l’idea di un progetto condiviso, che ha dato spazio a numerose ricerche inedite.
Come lavora con le fonti archivistiche e quali sorprese le ha riservato la documentazione?
Lavorare con le fonti archivistiche in Abruzzo non è facile, soprattutto a causa della dispersione e della perdita di una parte consistente della documentazione storica. Per questo motivo, un aspetto rilevante della mia ricerca è la letteratura storico-artistica prodotta tra la fine dell’Ottocento e la prima metà del Novecento. Ed è proprio da questa produzione che sono emerse le sorprese più significative. In particolare, colpisce la ricorrenza di un sentimento ancora oggi sorprendentemente attuale: la consapevolezza della scarsa tutela riservata al patrimonio artistico abruzzese. Alcune lettere d’epoca, ad esempio, mettono in luce le numerose criticità nella gestione e nella salvaguardia del patrimonio da parte delle istituzioni e delle comunità locali agli inizi del Novecento. A queste denunce si accompagna spesso un tono accorato, quasi paterno, intriso di preoccupazione per il destino delle opere d’arte e dei beni culturali.
Ci sono stati episodi o opere che l’hanno particolarmente colpita nel suo percorso di ricerca?
Non sono state le opere d’arte ma le persone a fare la vera differenza. Senza il prezioso supporto degli abitanti della Valle Siciliana, un territorio che comprende i comuni di Isola del Gran Sasso, Castelli, Tossicia, Castel Castagna e Colledara, non avrei potuto portare avanti la mia ricerca dottorale con la stessa profondità. È grazie alla loro disponibilità, ai racconti, alla memoria condivisa e al legame con il territorio che ho potuto accedere a fonti altrimenti introvabili e condurre indagini inedite, che hanno arricchito significativamente il mio lavoro.
Se potesse trascorrere una giornata in compagnia di un artista del passato, chi sceglierebbe?
Difficile rispondere, ce ne sarebbero molti. Ma, potendo ampliare il campo oltre le arti visive, sceglierei un grande “artista della parola”: Victor Hugo. Con lui non mi basterebbe una sola giornata.
Cos’è, per lei, l’eredità più importante che la ricerca umanistica può lasciare alle nuove generazioni?
La capacità di riflessione. Ma non solo, anche la possibilità di leggere il presente alla luce del passato, non per riportare in vita ciò che è stato, ma per capire ciò che del passato ancora ci abita, ci condiziona o ci interroga. Concludo in tal caso con le parole di Johann Gustav Droysen: «Non sono le cose passate che, con la ricerca storica, diventano chiare, dal momento che esse sono passate; ma diventa chiaro quello che di esse, nell’hic et nunc, non è ancora tramontato, sia che si tratti di memorie di ciò che fu ed avvenne, sia di avanzi di ciò che non è stato ed avvenuto».
Un futuro da scrivere
L’evento ha voluto essere soprattutto un invito aperto a giovani ricercatori e ricercatrici a esplorare nuovi sentieri di indagine: lo spazio adriatico come crocevia culturale, dove ogni documento, ogni opera, ogni migrazione, è una traccia da seguire. Perché la storia dell’arte – e la storia in generale – è fatta di movimenti. E sono proprio questi movimenti, ancora oggi, a sorprenderci con la loro modernità.
Contaminazioni, intrecci, ritorni di fiamma storici. Dalla Serenissima all’Abruzzo, il passato torna a parlarsi in un linguaggio condiviso, vivo e attuale. Un ponte gettato sul mare, costruito con carta, colore e passione.


















