Tecnologia
Robotica, emozioni, etica e intelligenza

Si è svolta a Napoli la 17ª edizione della International Conference on Social Robotics + AI dal titolo “Emotivation at the Core: Empowering Social Robots to Inspire and Connect“.
di Antonio Virgili – vive presidente Lidu onlus
Mentre l’attenzione di molti è oramai concentrata sull’Intelligenza Artificiale e sui suoi effetti nei vari ambiti economici, giuridici e sociali, una disciplina ad essa parzialmente collegata procede con celeri passi, ma in modo meno appariscente, lungo un itinerario sempre più promettente e pervasivo. La Robotica, settore nel quale l’Italia è tra i Paesi più avanzati nel mondo, ci avvicina infatti progressivamente a quanto la fantascienza e la cinematografia ci hanno descritto come automi sempre meno distinguibili dagli umani. L’entità dell’evoluzione si desume anche dai temi che gli specifici convegni internazionali si trovano ad affrontare. E’ questo il caso del recente convegno svoltosi a Napoli, la 17ª edizione della International Conference on Social Robotics + AI dal titolo “Emotivation at the Core: Empowering Social Robots to Inspire and Connect“. Con il termine “Emotivation”, di origine psicologica, si uniscono due parole: emozioni e motivazione. Si cerca di fondere il potere delle emozioni a quello della motivazione per creare maggiori miglioramenti, ne sono un esempio gli studi condotti in Italia e negli USA con il progetto “The Human Affectome Project”.
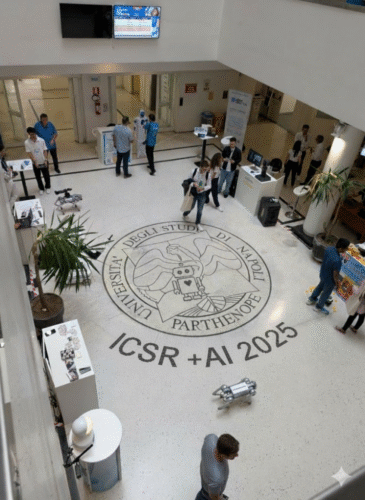
Le possibilità di impiego di sistemi robotici e dell’IA come assistenti degli esseri umani nello svolgimento di compiti di cura, di lavoro domestico, di selezione di informazioni in rete, di risoluzione cooperativa di problemi sono ampie. E si aprono di conseguenza nuove problematiche di etica applicata che portano a riflettere, nel contesto delle nuove forme di interazione uomo-macchina, circa la dignità, l’identità e la sicurezza della persona umana, la responsabilità individuale o collettiva, e l’accesso equo alle risorse tecnologiche e alla libertà di ricerca

Prof.ssa Daniela Rus,
Come ha sottolineato la Prof.ssa Daniela Rus, nell’ambito del Convegno di Napoli, accanto alla IA c’è l’intelligenza fisica. Già oggi circa 3,1 milioni di robot lavorano nelle fabbriche, facendo di tutto, dall’assemblaggio dei computer all’imballaggio delle merci e al monitoraggio della qualità e delle prestazioni dell’aria. Un numero molto maggiore di macchine intelligenti ha un impatto sulle nostre vite in innumerevoli altri modi, migliorando la precisione dei chirurghi, pulendo le case, estendendo la nostra portata a mondi lontani, e siamo all’apice di opportunità ancora più entusiasmanti. Le macchine del futuro, abilitate dai recenti progressi dell’intelligenza artificiale, saranno disponibili in diverse forme e materiali, incarnando un nuovo livello di intelligenza fisica. L’intelligenza fisica si ottiene quando il potere dell’intelligenza artificiale di comprendere testo, immagini, segnali e altre informazioni viene utilizzato per rendere intelligenti macchine fisiche come i robot. La sfida più immediata è però il bilanciare le capacità dell’IA con l’uso sostenibile dell’energia.
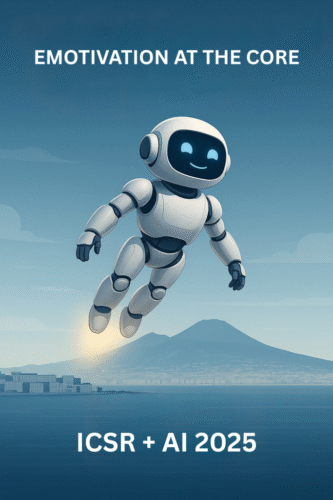
Per ottenere un’intelligenza fisica efficace, si ha bisogno di sistemi di intelligenza artificiale efficienti dal punto di vista energetico, in grado di funzionare in modo affidabile su robot, sensori e altri dispositivi “edge”. L’intervento della Prof.ssa Rus si è soffermato proprio sulle sfide energetiche dei modelli fondamentali di intelligenza artificiale, illustrando diversi modelli spaziali di stato al fine di raggiungere l’efficienza energetica e come i modelli spaziali di stato abilitano l’intelligenza fisica. Un modello spaziale di stato (State Space Model – SSM) è una architettura logico-matematica utilizzata per descrivere sistemi dinamici in termini di variabili di stato. Questi modelli sono particolarmente utili in campi come la teoria del controllo, l’economia e l’ingegneria, dove i sistemi evolvono nel tempo. La rappresentazione dello spazio di stato fornisce un modo completo per modellare il comportamento di sistemi complessi catturando i loro stati interni e le relazioni tra di essi.

L’immediato futuro della robotica sociale è umano-centrica, orientata a facilitare contatti e uso anche per utenti con limitazioni (bambini, anziani, malati), cercando addirittura di creare empatia. Nell’interazione tra esseri umani e macchine “adattative” o “intelligenti”, si parla oramai di sistemi robotici progettati per svolgere compiti di servizio, di assistenza o di intrattenimento, dotati di capacità crescente di lettura e comprensione degli umani. Sistemi che possono identificare vari indizi non verbali dello stato emotivo degli utenti, elaborati a partire sia dalla rilevazione di dati biometrici correlabili a risposte emotive, così come dall’esame di gesti, postura e altri comportamenti manifesti dei soggetti (es.: la pressione esercitata istante per istante sul mouse del calcolatore). Ecco perché si parla di emozioni, di motivazioni, di intelligenza adattativa delle macchine finalizzate ad interazioni complesse tra persone e sistemi robotici. Oltre al già presente problema energetico, è chiaro che grande peso hanno, e avranno, gli investimenti e i mezzi in campo in questo settore. Su questi aspetti, nonostante le eccellenze europee ed italiane, sarà sempre più difficile competere con le masse ingenti di capitali e strutture di cui possono disporre USA e Cina. Bisogna interrogarsi subito su questo aspetto e cercare soluzioni efficaci e il più possibile autonome, se si vuole conservare un ruolo per i Paesi europei.
















